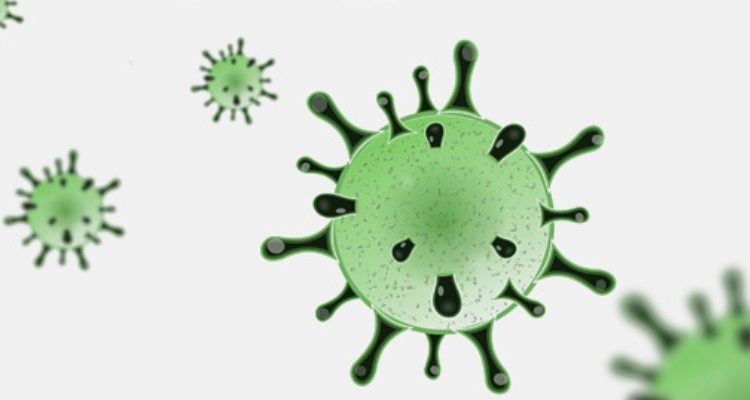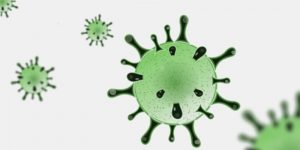 Roma – Partiamo con una metafora: durante una partita a scacchi, un vento forte comincia a spostarci i pezzi. Ora troviamo le torri al centro e i cavalli agli angoli, i neri al posto dei bianchi e i pedoni a metà tra una casella e l’altra, senza più capire se sono in F5 o F4, ad esempio. La scacchiera è la società e il vento, cioè lo Scompiglio, è un’epidemia qualsiasi o – facciamo così – il coronavirus. Faccio un passo indietro e mi spiego meglio.
Roma – Partiamo con una metafora: durante una partita a scacchi, un vento forte comincia a spostarci i pezzi. Ora troviamo le torri al centro e i cavalli agli angoli, i neri al posto dei bianchi e i pedoni a metà tra una casella e l’altra, senza più capire se sono in F5 o F4, ad esempio. La scacchiera è la società e il vento, cioè lo Scompiglio, è un’epidemia qualsiasi o – facciamo così – il coronavirus. Faccio un passo indietro e mi spiego meglio.
Vado a memoria, ma sono abbastanza sicuro di poter dire che non c’è stato mai fenomeno, nella storia, – almeno quella italiana – vissuto nel modo in cui si sta vivendo il coronavirus. Qualcuno potrebbe pensare a casi ben più drastici come quelli delle guerre mondiali o, per non andare troppo indietro, delle Torri Gemelle. Ma c’è una pedina che prima non c’era: i social network.
Pensate: da qualche settimana – soprattutto da quando è uscito fuori il caso del cosiddetto paziente 1, in Lombardia – il 90% delle notizie è concentrato sulla questione coronavirus. I telegiornali si aprono col conteggio degli infetti, ogni sera le testate riportano i bollettini della protezione civile e la partita della stessa politica si gioca ormai sulla questione virus, ne è toccata concretamente (si pensi al caso Zingaretti). Mai un fatto di cronaca ha rapito l’attenzione dei media con una tenacia così duratura e pervicace, se si pensa che ne avremo a che fare tutti i giorni a tutte le ore per i prossimi mesi. E questo è il motivo per cui – nonostante il mondo di brutte bestie ne abbia viste e ne veda peggiori, e parecchie – ce ne ricorderemo a lungo.
La chiave di volta sta, come dicevo, nella diversa struttura del mondo comunicativo. Il sistema televisivo, che ha imperato fino ai primi anni ’10, è ormai in completa concorrenza (e si avvia all’abdicazione) con quello dei social network. Questa trasformazione non implica semplicemente una variazione quantitativa (maggior numero di input e news, tempo reale, aggiornamenti secondo per secondo), ma certamente anche una variazione qualitativa: possiamo partecipare tutti alla condivisione, alla rielaborazione dei dati e di conseguenza alla costruzione stessa dell’immaginario – ad esempio – dell’Italia in quarantena. Il modello televisivo era (ed è) unidirezionale: il TG parla, lo spettatore ascolta. Il modello internettistico, e specialmente social, è orizzontale e multiversale: qualcuno (dalla testata giornalistica al semplice cittadino) dà un input; tutti gli altri lo interpretano, giudicano, contestano, approvano. A uscirne fuori completamente riformulata è la coscienza dell’evento: il coronavirus – ma il discorso è ovviamente più generale – non è una notizia, è una deformazione dello spazio sociale, sia virtuale che concreto (ed anzi, con la sovrapposizione dei due). In questo spazio non solo noi siamo inseriti ma – volenti o nolenti – contribuiamo alla sua modificazione. Non è certo un caso che il decreto recente che fa dell’Italia intera una “zona protetta” è legato a doppio nodo – parola del premier – a uno slogan, a una campagna social con tanto di hashtag, #iorestoacasa, che funziona da bussola delle azioni in maniera molto più efficiente di ogni polveroso faldone legislativo. Non a caso proliferano – ecco il punto – le iniziative popolari di diario della quarantena, di riflessione comune, di cui quest’articolo, per giunta, è ennesimo esempio.
Ecco allora che un virus, anche se fisicamente lontano da noi, può diventare una plastica virtuale sociale in queste precise condizioni storiche, una sorta di spaziotempo alterato in cui siamo inseriti e interagiamo: è la dimostrazione (la prima di impatto così grande e duraturo, vista la diretta conseguenza dei comportamenti di ognuno sulle vite degli altri e dello Stato) che la percezione della storia non è più un fatto libresco, non è più “solo” un fatto di apprendimento eterodiretto, ma è – fino a certa misura – prassi, favorita dal plasma di opinione e azione pubblica che è il social. Sul valore umano di questa condizione, sulla possibilità di discernere, poi, la verità nel social, e di quale spessore è lo scollamento tra reale e virtuale, non mi pronuncio. Sarebbe lungo e complesso.
Mi sembra, comunque, siano facilmente leggibili attraverso questa chiave tutte le azioni più o meno scriteriate che hanno accompagnato il dilagare del virus in Italia in questi giorni: la fuga dal nord al sud per evadere dalla zona rossa, l’affollamento in coda ai supermercati, le razzie al loro interno, i taxi a 1200 euro, Amadeus, ecc. ecc. Se non vogliamo parlare di psicosi collettiva (che è una questione seria, e va affrontata con cognizione di causa), possiamo certo però osservare come in epoca facebookiana e instagramiana l’azione del singolo non è l’azione del singolo ma una relazione quantistica, una frizione che accade in uno spazio collettivo virtuale che è decalcomania, però, di quello reale. Ecco lo Scompiglio della scacchiera: mettiamo un episodio scatenante (un’epidemia) in un contesto di ordine (una scacchiera), e tutti i pedoni cominciano non solo a cambiarsi di posto, ma anche a stare a metà tra un posto e l’altro, a riformare le regole, trasgredirle e giudicarle – perché fanno parte dello stesso magma collettivo e sono pezzi di interazione in un mondo quanto mai interattivo.
Che fare, allora, in questa situazione? Chiudere questo articolo (che è una semplice riflessione sul rapporto tra virus e media) con un messaggio moralistico, sarebbe inadeguato e fuori dal mio stile. Mi limito a sottolineare che tutta questa possibilità di coscienza aumentata che la rete ci consente è appunto una possibilità, e perciò bisogna sapersela sfruttare. Bisogna guadagnarsela, motivarla, coltivarla. Bisogna impedirne la distorsione. E il senso civico di cui molto si parla non è altro che l’applicazione di questo postulato: che il senso del collettivo prevalga sugli interessi dei singoli è ciò che ci auguriamo. Seguirlo, è ciò che ci spetta.