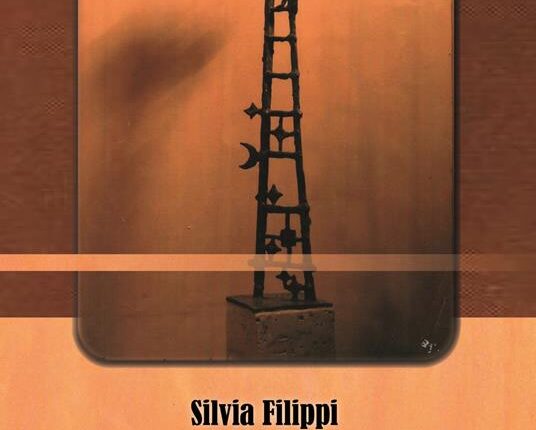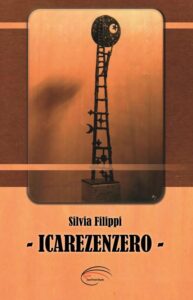 Tivoli – In linea di massima, dalle aree interne e dalle province, ad esempio dalla Valle dell’Aniene, si va via. Così non è in Icarezenzero (Pluriversum Edizioni, 2022), l’ultimo romanzo di Silvia Filippi. Qui, all’opposto, e come rarissimamente accade nella narrazione della Valle (e di molte altre zone periferiche), la marginalità è un luogo in cui si arriva, l’approdo di una ricerca.
Tivoli – In linea di massima, dalle aree interne e dalle province, ad esempio dalla Valle dell’Aniene, si va via. Così non è in Icarezenzero (Pluriversum Edizioni, 2022), l’ultimo romanzo di Silvia Filippi. Qui, all’opposto, e come rarissimamente accade nella narrazione della Valle (e di molte altre zone periferiche), la marginalità è un luogo in cui si arriva, l’approdo di una ricerca.
I protagonisti del romanzo, Adelia, Irene e Osias, sono infatti tutti migranti: Adelia dal Portogallo di Salazar, Irene da una città (Roma) non più a misura d’uomo, Osias da un Congo devastato. Naturalmente, oltre che dal luogo, ognuno di loro fugge (tenta di fuggire) anche da una sfera della propria vita, dall’orfanità, dall’insuccesso esistenziale – ma ciò che è davvero rilevante, da questa prospettiva, è che i tre si ritrovino nelle campagne di Tivoli, dove Adelia ha aperto uno strano e anti-economico b&b, e che qui trovino una quiete, una possibilità (per il tempo e la concentrazione ritrovata, per un dialogo rifondato con il mondo esterno, e interno) di ricostruire il senso della propria esistenza.
Tivoli e la sua campagna, dunque, agiscono come veri personaggi all’interno della storia, funzionano proprio nella loro marginalità, nel loro deserto, anche, come meccanismi di disinnesco dell’alienazione e della fuga. Non è un caso che il romanzo insista molto su quella curva, tra Tivoli città e Villa Adriana, nota come «curva del regresso»: si torna indietro, lì, si regredisce, ma nel senso della riconquista di qualcosa di perduto (e cioè, in soldoni, la presenza di sé a se stessi).
A contribuire a questa funzione della Valle come area della quiete che irrompe nella frantumazione contemporanea dei rapporti umani, e dei rapporti uomo-mondo, c’è l’atmosfera sospesa del romanzo. Il libro, infatti, pur seguendo la storia dei tre protagonisti, la racconta in maniera sfalsata, con flashback e digressioni; in più inframezza i capitoli con brani meta-narrativi o vere e proprie poesie che bucano la narrazione e la mettono in tensione anche con un piano diverso, appunto sospeso, irrisolto, immaginifico.
Trasversalmente, è il segno della difficoltà di rappresentare un mondo calcificato da narrazioni stereotipate o, al più, assenti. Ed è per questo che, nonostante la funzionalità nuova di Tivoli come spazio di liberazione, invece che di costrizione, Filippi non si adagia su questo, e anzi lo complica felicemente aprendone anche il lato distruttivo: alla fine della storia – attenzione, spoiler – il locus amoenus è distrutto da un incendio e i protagonisti sono costretti, di nuovo, a migrare.
Non si tratta solo di un’occhiata alla questione climatica (pure presente); di più, l’incendio è lo yang della quiete, e così come la provincia viene offerta come spazio «per visitare pure sé stessi», e la collettività, insieme è riconosciuta come spazio minacciato (che prende fuoco) e minacciante (che dà fuoco). Il merito di Icarezenzero, io credo, è di tipo immaginativo: ripensare la rappresentazione della provincia, prenderne di petto e senza patetismi le possibilità emancipatorie e il potenziale inferno.