“Racconti e poesie” di Isidoro Console La Rosa: la scrittura come studio “dal basso” tra Sicilia e Valle dell’Aniene
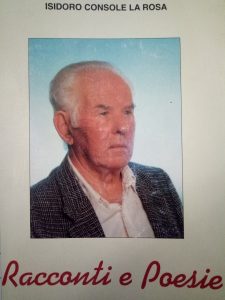 Vicovaro – Scoprire il punto di vista letterario (e non) di Isidoro Console La Rosa significa in prima battuta osservare lo spazio che abitiamo quotidianamente da una prospettiva alterata, diversa. La Rosa era infatti siciliano, di Misterbianco: dopo un’infanzia difficile, l’istruzione precaria, il barcamenarsi tra lavori occasionali e faticosi, fu costretto a emigrare, a causa della guerra, e a rifugiarsi a Vicovaro, dove poi si stabilì definitivamente. La sua scrittura nasce perciò innanzitutto da un bisogno esistenziale di riscatto, dal tentativo di sublimazione estetica di una vita segnata dallo sradicamento e dalla rinuncia. Racconti e poesie, uscito nel 1998, offre una summa della sua attività scrittoria, ne svela i caratteri fondamentali, che qui di seguito cercherò di studiare.
Vicovaro – Scoprire il punto di vista letterario (e non) di Isidoro Console La Rosa significa in prima battuta osservare lo spazio che abitiamo quotidianamente da una prospettiva alterata, diversa. La Rosa era infatti siciliano, di Misterbianco: dopo un’infanzia difficile, l’istruzione precaria, il barcamenarsi tra lavori occasionali e faticosi, fu costretto a emigrare, a causa della guerra, e a rifugiarsi a Vicovaro, dove poi si stabilì definitivamente. La sua scrittura nasce perciò innanzitutto da un bisogno esistenziale di riscatto, dal tentativo di sublimazione estetica di una vita segnata dallo sradicamento e dalla rinuncia. Racconti e poesie, uscito nel 1998, offre una summa della sua attività scrittoria, ne svela i caratteri fondamentali, che qui di seguito cercherò di studiare.
Prima di tutto, La Rosa era un poeta ingenuo. Nella parola “ingenuo” c’è una densità di significato che l’uso consueto tende a cancellare: per “ingenuo” intendiamo fesso, inadeguato, e dimentichiamo frequentemente il suo significato di genuino, non sottomesso al giogo della scaltrezza e malizia sociale. La Rosa è ingenuo perciò nel senso che offre una poesia spesso semplice, immediata, ma anche radicata a interrogativi fondamentali e originari; aveva ragione Giuseppe Pomponi quando proprio nella Prefazione a Racconti e poesie scriveva: «Le poesie, alcune ingenue, altre profonde, sono “frutti di bosco” genuini e spontanei, “fiori di campo” che un intenditore sa riconoscere ed apprezzare, offerti al lettore con il garbo del siciliano verace.»
La coscienza letteraria di La Rosa va letta quindi in relazione alla sua doppia radice geografica, tra la Sicilia e Vicovaro, spazi che lui guarda in modo molto diverso sebbene con la stessa intensità d’affetto: la Sicilia è un luogo ancestrale, legato all’infanzia, mitico, e mitico soprattutto nella forza nera che sprigiona, nelle predestinazioni incontrovertibili (si vedano le poesie Ricordi d’infanzia e I miei amori distrutti e abbandonati); Vicovaro invece è luogo d’arrivo, quindi La Rosa lo osserva sempre con un certo distacco, che può così esercitarsi, concretamente, o nella lode/analisi di alcuni spazi vicovaresi (poesie Come ti vedo Vicovaro, Al palazzo di Vicovaro, A San Rocco di Vicovaro) o nel rivolgersi alla discendenza, alla proiezione generazionale (A mio nipote Giovanni Bernardini, A Valentina Vasselli mia nipote), perciò in entrambi i casi in un moto a luogo (figurato), in un’ode.
Anche nei racconti, che occupano la prima parte del libro, il mondo siciliano è lontano e oscuro nella sua grandezza o tragedia, e il discorso può facilmente farsi cronaca, come nel caso di Giuseppina a Malpassota. Cronaca siciliana di fine Ottocento (e del resto accade anche per Vicovaro con la poesia Vicovaro 1971 Tragedia a piazza San Pietro), che riesce nell’aderenza della narrazione al narrato meglio di quanto non facciano gli altri racconti, più fondati su una visione un po’ stereotipata di novella avventurosa (come nel caso di Gil Juseppet, il Cavaliere Nero, di atmosfera a metà tra Sciascia e Tex Willer).
La seconda parte del libro, quella poetica, rimane più interessante proprio per la sua maggiore spontaneità, l’assenza di una sovrastruttura eterodiretta (derivata, magari, dal mondo cinematografico o fumettistico) che sopprima lo slancio estetico primigenio. Possiamo raggruppare le liriche in filoni ben distinti, che vanno da quello romantico (il più stereotipato) a quello religioso (sebbene spesso si risolva in liturgia schietta, la fervenza religiosa è una delle componenti fondamentali dell’opera), da quello testimoniale (cronachistico o geografico) a quello esistenziale (il più interessante e denso, perché qui si esplica la vera ragione della poesia di La Rosa, come ora mostrerò).
Questi contesti sono tutti affrontati con una lingua che risente dell’origine siciliana, da una parte (oltre alle poesie interamente in vernacolo, come T’amu terra mia, non sono rari i sicilianismi inseriti in testi non dialettali – come quel «l’anima mia si ricria» in Il passaggio – spesso dettati da ragioni foniche, in stile rima siciliana inventata dagli antichi autori toscani del ‘200), e della mancata istruzione, dall’altra. Quest’ultima spinta (o contro-spinta) è visibile in alcune imprecisioni grammaticali, negli anacoluti (che comunque possono favorire soluzioni poetiche efficaci, come nel verso «I nonni contiamo poco», in A mio nipote Giovanni Bernardini); ma proprio in essa è covata la vena poetica originale dell’autore, quel bisogno metafisico incontrollabile che scavalca l’istruzione e punta dritto alle domande fondamentali.
Per leggere oggi La Rosa dobbiamo allora seguire un procedimento archeologico: scrostare i suoi testi dalla patina carducciana o negativamente folkloristica (la maggior parte delle poesie segue uno schema di quartine cadenzate, sebbene in verso libero, con rime o assonanze alternate, spesso a mo’ di filastrocca, e ed è ricca di apocopi), e leggerne i presupposti profondi, che sono quelli di un contadino prestato al mistero del mondo. È La Rosa, nell’Introduzione, a dichiarare la causa scatenante del suo verso: «Con la mia esperienza da ragazzo, ho capito che in me vi era qualcosa di soprannaturale che mi ha incuriosito ancor di più adesso che son rimasto vedovo; dato che lavoro in campagna ho studiato come meglio ho potuto, cominciando dalle cose più semplici e naturali a portata di mano per chiunque. Per esempio: ho osservato il movimento della terra ed ho visto che mediante la spirale nord e sud ha quattro oscillazioni. [seguono altre osservazioni di movimenti animali naturali che ruotano tutti allo stesso modo]. Come si spiega ciò? Così ho appreso che l’uomo può trovare qualcosa di interessante, come l’ho trovato io, perché questa è la “realtà” dei fatti, ma purtroppo non ci si fa caso».
La poesia di La Rosa viene dall’osservazione della terra, dallo sguardo contadino ingenuo – nel senso indicato in apertura – e i poeti per lui «Son angeli che Iddio / invia tra la gente. // Per dire e per dare / che amar non costa niente, / per dire ciò che vedono, / per dare ciò che pensano.» (I poeti). Un compito gnoseologico-testimoniale (osservare, scoprire, riportare), dunque, e un compito morale-evangelico, che dietro “l’ingenuità”, anzi proprio tramite l’ingenuità, fanno di La Rosa un poeta fiducioso nello strumento del verso, un contadino che manipola la terra e la parola con la stessa libertà, con lo stesso entusiasmo di partecipare a qualcosa di più grande degli uomini: «Ca’ volta mi domando e dico / convien vivere senza un perché? / Eppure intravvedo e sento d’antico / ove è rimasto qualcosa di me.»


